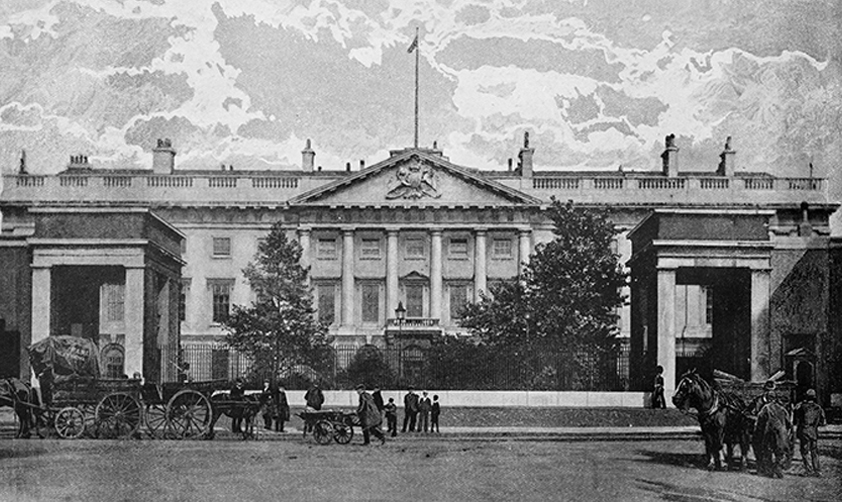Chi non ha sentito parlare di Alessandro Magno? Non fosse altro che per gli innumerevoli film e libri a lui ispirati. Ma chi era veramente Alessandro Magno? E che ruolo ha avuto in campo monetale e monetario?
Alessandro era figlio del re macedone Filippo II e nel 336 a.C., appena ventenne, successe al padre.
Fin da subito manifestò l'intenzione di portare avanti il progetto paterno di muovere guerra alla Persia per vendicare i Greci dell'invasione subita circa centocinquant'anni prima. Sbarcato in Asia Minore nel 334 a.C. avanzò sempre di più nei territori dello Stato Persiano, concependo man mano l'idea di creare un impero universale. E così fece, riuscendo a fondare un impero che dai Balcani arrivava fino all'Egitto e all'India, con capitale Babilonia.
Con lui la monetazione greca subì importanti cambiamenti.
Già con Filippo II l'occupazione della regione del monte Pangeo con le sue ricche miniere d'oro (zona nord-orientale dell'odierna Grecia) aveva permesso l'emissione di numerose monete auree, cosa che fino ad allora era stata in tutta la Grecia piuttosto rara e legata a situazioni straordinarie o a momenti di crisi. Alessandro, che impose una moneta unica in tutto il suo vasto impero, poté emettere in oro stateri (questo il nome delle monete) e loro sottomultipli (metà, quarti e ottavi) oltre a doppi stateri, utilizzando come unità di misura il piede attico.
Sul dritto degli stateri e dei doppi stateri, come è stato possibile notare nell'esemplare esposto nella mostra immersiva "L’Avventura della Moneta", era raffigurata la testa della dea Atena con elmo corinzio (fig. 1), mentre al rovescio era riprodotta una Nike (personificazione della vittoria) alata stante. A destra della Nike correva un'iscrizione, ALEXANDROU (moneta di Alessandro) (fig. 2).


Sui tetradrammi d'argento, invece, era rappresentata al dritto la testa di Eracle con la leonté (pelle del leone nemeo, trofeo della sua prima fatica) e al rovescio Zeus seduto in trono sul modello fidiaco. È verso la fine del suo regno (Alessandro muore prematuramente per una malattia nel 323 a.C.) che sulle monete assistiamo a un'assimilazione del sovrano con Ercole.
Proprio l'affermazione dell'uso, derivato dal mondo orientale e assolutamente estraneo al mondo della grecità classica, di riprodurre sulla moneta il ritratto del sovrano, rappresenta la novità più evidente della monetazione di Alessandro. Ma come se la figura umana non osasse sostituirsi improvvisamente a quella degli dei, l'immagine è rivestita di un contenuto religioso, attraverso la sua divinizzazione o la sua identificazione con la divinità (Ercole).
Anche dopo la sua morte per lungo tempo continuarono a essere emessi i tetradrammi con l'effigie di Alessandro, accanto alle nuove monete con i ritratti dei suoi successori, i "diadochi", anch'essi divinizzati.
La moneta da quel momento divenne un simbolo del potere del sovrano e della sua autorità assoluta; non più tutelata dall'immagine delle divinità, si trasformò in uno strumento di propaganda e di potere. E con questa accezione, soprattutto a partire dal I secolo a.C., l'uso del ritratto si diffuse nella monetazione romana.
La moneta era, infatti, il mezzo più idoneo per diffondere nei territori più vasti l'immagine che il potere politico voleva dare di sé, uno strumento autocelebrativo di portata eccezionale, che può paragonarsi ai nostri moderni sistemi di comunicazione di massa. Essendo oggetti di scambio, le monete giravano ovunque, all'interno e all'esterno dei propri confini e chiunque aveva la possibilità di riconoscere le persone che vi erano raffigurate e di cogliere il messaggio che questi volevano trasmettere.
Alessandro, dunque, si appropriò di questo efficace veicolo comunicativo per propagandare la propria immagine, rendendo eterne le sue gesta. L'attenzione che pose nella costruzione della propria figura si può anche riconoscere nell'abilità con cui seppe sfruttare quello che probabilmente era un piccolo difetto fisico, forse una leggera scoliosi, tramutandolo in una sua peculiarità: così sarà sempre ricordato, con la tipica torsione del collo e lo sguardo proteso verso l'alto come se fosse impegnato in un continuo dialogo con la divinità.